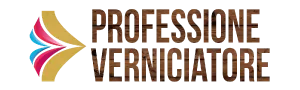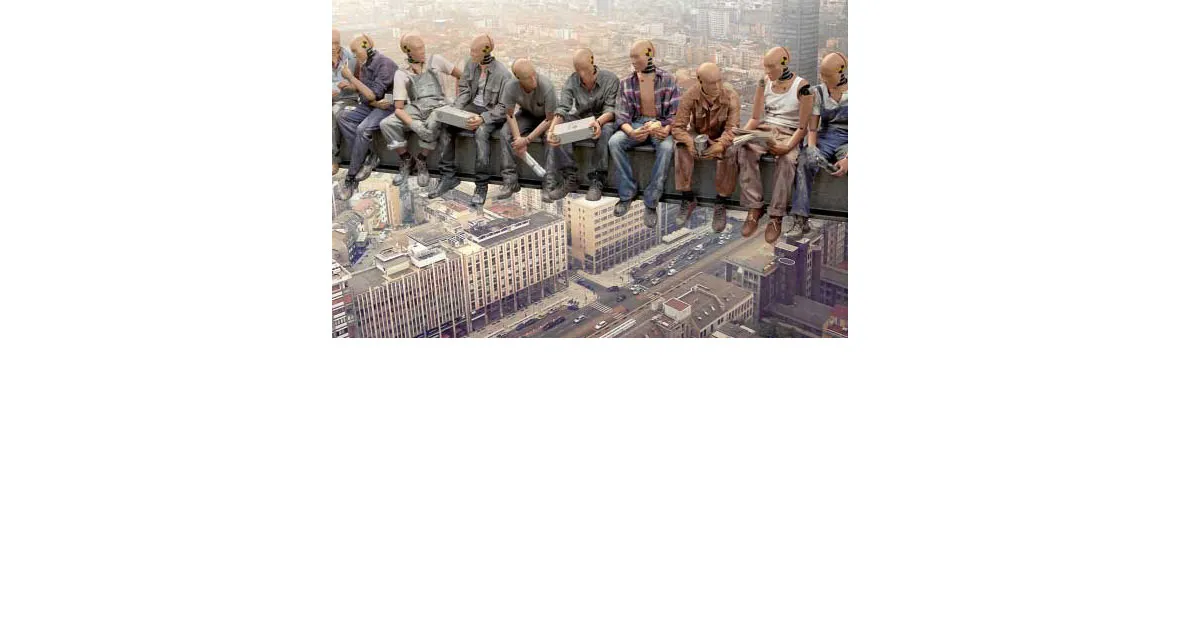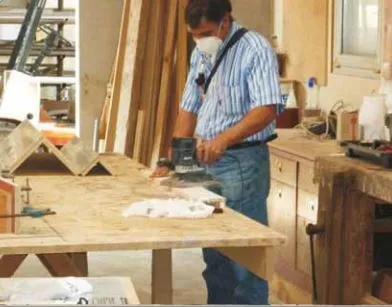La filtrazione degli inquinanti con reimmissione dell’aria nell’ambiente di lavoro è legale?
A cura di Pierluigi Offredi
PREMESSA
In linea di principio gli esperti di sicurezza e igiene industriale sconsigliano l’impiego di impianti di abbattimento degli inquinanti con ricircolo dell’aria trattata in ambiente di lavoro, in particolare quando si utilizzano sostanze chimiche dotate di proprietà sensibilizzanti, cancerogene o mutagene. Nella mia esperienza professionale solo in rari casi ho visto derogare da questo principio e solo in specifiche situazioni lavorative, come ad esempio nelle attività artigianali di falegnameria insediate nei centri storici, dove esistono difficoltà oggettive a portare le emissioni all’esterno. In aziende di dimensioni ben maggiori (ad esempio nel caso di Foppa Pedretti, noto produttore di elementi di arredo in legno) le deroghe sono state concesse per ottenere un consistente risparmio energetico, che si è tradotto anche in una riduzione dell’impatto ambientale complessivo, specie nei mesi invernali, riducendo la quantità di aria espulsa dai reparti riscaldati. Infine nel settore metalmeccanico è noto a tutti il caso di Brembo, nota azienda specializzata nella produzione di componenti auto motoristici, che ha ottenuto l’autorizzazione ad aspirare e depurare le nebbie oleose e i fumi generati dalle lavorazioni meccaniche con utilizzo di oli lubrorefrigeranti, re immettendo l’aria nell’ambiente di lavoro, in conformità con l’allegato tecnico 32 del DDUO 12772, 23/12/2011 emanato dalla Regione Lombardia. I casi di reimmissione dell’aria nell’ambiente di lavoro, nel nostro Paese sono talmente rari che l’applicazione desta dubbi e perplessità tra gli operatori del settore e non è facile reperire dati sul campo. La mancanza di coordinamento tra gli Enti pubblici e la ritrosia delle aziende che hanno con fatica ottenuto l’autorizzazione, sono le cause principali della difficoltà di diffondere numeri ed esperienze pratiche, ma io ritengo che il motivo principale consista nell’incertezza normativa esistente in questo specifico campo, che lascia spazio ad interpretazioni soggettive e spesso arbitrarie, dando agli operatori del settore un senso di incertezza sulle modalità e le procedure da seguire per ottemperare ai precetti legislativi.
IL CONCETTO DI “MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE POSSIBILE”
Il datore di lavoro ha l’obbligo di essere aggiornato sulle conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso scientifico e tecnologico. E’ questo il principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, desumibile dalla nostra legislazione, che più di ogni altro caratterizza il modello italiano di prevenzione e che trova conferma nella legislazione di derivazione comunitaria. La giurisprudenza ha sempre interpretato quest’obbligo in maniera piuttosto restrittiva, anche se il limite della cosiddetta “fattibilità tecnologica”, enunciato dall’art. 3 del vecchio D.Lgs. n. 626/1994 e ribadito dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, potrebbe dare spazio a interpretazioni meno rigide. Il riferimento principale su questo tema è la nota sentenza della Corte costituzionale del 25 luglio 1996, n.312, intervenuta per valutare se l’eccessiva genericità del principio contenuto nell’art. 41, 1°comma, del d.lgs.n.277/1991 (che impone al datore di lavoro di ridurre al minimo, “in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte”) fosse in contrasto con l’art.25, 2°comma, della Costituzione, relativo alla necessaria determinatezza delle previsioni della legge penale. Secondo la sentenza della Corte, la sola via per evitare la violazione della Costituzione è quella di restringere la soggettività dell’interpretazione. Quindi quando si parla di misure “concretamente attuabili”, il legislatore si deve riferire “… alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive. Ed è in questa direzione che dovrà, di volta in volta, essere indirizzato l’accertamento del giudice: ci si dovrà chiedere non tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli standard di produzione industriale, o specificamente prescritta”. Il mutamento rispetto al passato è evidente: non si parla più di “sicurezza massima possibile” ma di ciò che è generalmente acquisito e praticato sul piano delle misure tecniche, organizzative e procedurali, nei diversi settori produttivi. Ma quali sono gli “standard di sicurezza”? Quali sono le misure “generalmente praticate o acquisite”? Soprattutto non c’è il rischio di scoraggiare la diffusione di tecnologie di prevenzione del rischio migliorative rispetto allo standard medio? Il principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” si ritrova spesso in molte disposizioni del d.lgs. n.626, sia nella parte prima (misure generali di tutela), in cui si prevede “l’eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo” (art.3, 1° comma, lett.b) e degli obblighi a carico degli imprenditori, che devono aggiornare “le misure di prevenzione in relazione (tra l’altro) al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione” (art.4, 5° comma, lett.b), sia nelle parti specifiche, dove si parla di sostituzione e riduzione degli agenti cancerogeni (art.62). Tutti questi concetti sono stati ribaditi nel D.Lgs. n. 81/2008. Anche una sentenza della Corte di Giustizia europea del 15 novembre 2001, in causa n.C 49/00, precisa che “i rischi professionali che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali”.
QUAL E’ IL PREZZO DELLA SICUREZZA?
Dal punto di vista teorico si sfidano due “filosofie”: da una parte c’è il principio della “massima sicurezza ragionevolmente praticabile”, proprio dell’ordinamento britannico (Health and Safety at Work Act, del 1974), che consente al datore di lavoro di sottrarsi alle proprie responsabilità qualora dimostri che l’adozione di misure che garantiscono la sicurezza e la salute dei lavoratori sia sproporzionata in termini di costi, di tempo o di difficoltà rispetto al rischio effettivo, dall’altra c’è una visione più cautelativa, espressa da numerose sentenze italiane, in cui si sottolinea che la sicurezza non va subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva e il datore di lavoro è tenuto ad allineare il proprio assetto produttivo e organizzativo ai risultati raggiunti dal progresso scientifico e tecnologico. A questo proposito val la pena di citare il 13° considerando della direttiva n.89/391, in cui si afferma con chiarezza che “il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico”.
SICUREZZA E NORMATIVA TECNICA
Secondo la disciplina italiana ed europea le “norme di buona tecnica”, cioè le specifiche tecniche emanate da determinati organismi nazionali, europei e internazionali (UNI, Ente nazionale di unificazione in Italia, CEN, Comitato europeo di normalizzazione, in Europa, ISO, Organizzazione internazionale per la standardizzazione, nel mondo) sono norme volontarie, non vincolanti. In Italia, nel settore elettrico e del gas, oltre a stabilire l’obbligo di rispettare la “regola d’arte” in materia di sicurezza, il legislatore ha specificato che le norme tecniche, codificate dal CEI o dall’UNI, costituiscono un criterio di presunzione legale di conformità ai requisiti di sicurezza. In sede giudiziaria, quando a fronte di incidenti sul lavoro viene verificato se l’azienda ha utilizzato le migliori tecnologie disponibili, si prende come riferimento la conformità alle norme tecniche, che in questi casi diventano quindi cogenti.
LA NECESSITÀ DI DATI SCIENTIFICI
Gira e rigira, si torna sempre al concetto di “migliore tecnologia disponibile”. Per affrontare il problema in modo tecnico e non ideologico è necessario conoscere l’efficacia dei sistemi di filtrazione, le loro modalità di manutenzione e di mantenimento dell’efficacia, la possibilità di reale controllo della qualità dell’aria nell’ambiente di lavoro, in modo da fissare i requisiti minimi necessari per valutare l’ammissibilità dei sistemi di abbattimento a ricircolo dell’aria, così come è stato fatto per gli impianti di depurazione dell’aria espulsa all’esterno delle fabbriche, che sono stati definiti dalle norme tecniche UNI 10996, utilizzate dalla Regione Lombardia per definire i requisiti minimi che consentono l’autorizzazione degli impianti. Nello specifico, ritengo che la corretta filtrazione degli inquinanti, preliminare alla reimmissione dell’aria in ambiente di lavoro, nell’oggettiva impossibilità di controllare a tappeto gli ambienti di lavoro da parte degli Enti competenti, possa essere parzialmente garantita dall’impiego di impianti conformi alla normativa. Ad esempio, nel caso delle polveri di legno la norma di riferimento è la UNI EN 12779:2010 del 1/1/2010, Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Sistemi fissi di estrazione di trucioli e polveri – Prestazioni correlate alla sicurezza e requisiti di sicurezza. La norma stabilisce i requisiti prestazionali relativi alla sicurezza e specifica i metodi per l’eliminazione dei pericoli o le misure che devono essere adottate per minimizzare i pericoli dei sistemi fissi di estrazione di trucioli e polveri, connessi alle macchine per la lavorazione del legno, progettate per tagliare legno massiccio, pannelli di particelle, pannelli di fibra o legno compensato e anche questi materiali ricoperti con laminati plastici o bordi. Tra i requisiti previsti, l’impianto deve essere in grado di garantire un contenuto di polveri nell’aria di ritorno inferiore a 0,2 mg/m3. Si tratta dello stesso principio applicato anche all’aspirazione e depurazione di nebbie oleose e fumi generati da lavorazioni meccaniche con utilizzo di oli lubrorefrigeranti, con reimmissione dell’aria nell’ambiente di lavoro (allegato tecnico 32 del DDUO 12772, 23/12/2011 Regione Lombardia). Ovviamente sugli impianti dovrebbe essere fatta regolarmente una manutenzione periodica, riportata su appositi registri validati, ma qui si torna al problema dei controlli, che in questo Paese sembrano diventati un lusso che non possiamo più permetterci. Il principio della “Responsibility”, più di moda rispetto al “Command and control”, sta ispirando negli ultimi anni la legislazione europea, ma sulla sua efficacia nutro seri dubbi, per lo meno per quanto riguarda l’applicazione in Italia. Sembra però che questo approccio sia diventato ormai irreversibile e indiscutibile, almeno tanto quanto lo sforamento dei limiti previsti dal “Patto di stabilità e crescita”.
IL CASO DI FIRENZE
Leonardo Bonini, Fabio Capacci, Carla Sgarrella, Silvia Castellacci, Maurizio Baldacci (Dipartimento della Prevenzione, U.F. PISLL zona Firenze ASL di Firenze2) e Claudia Cassinelli (Laboratorio di Sanità Pubblica zona Toscana Centro, ASL di Firenze), hanno realizzato uno studio, pubblicato sulla rivista AIDII e per gentile concessione di IJOEHY anche su “Professione Verniciatore”, sulle attività di falegnameria artigianale a Firenze.
Sulla base dei risultati dell’indagine realizzata sul campo e prendendo spunto dagli indirizzi contenuti nella scheda tecnica sugli impianti a ricircolo dell’aria redatta dalla Regione Emilia Romagna [Arcari et al., 1991], l’ammissibilità della reimmissione dell’aria filtrata in aziende di lavorazione del legno, mediante l’uso di impianti ad ultra-filtrazione, deve rispettare i seguenti punti:
tutti i macchinari per la lavorazione del legno devono essere serviti da bocchetta di aspirazione e l’impianto deve essere sezionabile mediante valvole d’intercettazione, possibilmente pneumatica;
devono essere effettuati campionamenti ambientali fissi e personali secondo le norme UNI EN 481 e 689, per valutare l’esposizione professionale a polveri del legno ed il rispetto del valore limite;
l’impianto deve avere un sistema di misura della pressione differenziale per controllare il livello d’intasamento del filtro ed un sistema di pulizia manuale o pneumatico dei filtri;
l’impianto deve essere dotato di allarme ottico o acustico che segnali l’intasamento del filtro;
l’impianto deve essere in grado di garantire un contenuto di polveri nell’aria di ritorno inferiore, almeno, a 0,2 mg/m3;
la sostituzione periodica dei filtri deve avvenire secondo procedure di protezione individuale ben codificate;
deve essere garantita immissione di aria esterna secondo i criteri generali della ventilazione industriale.
Il rispetto di questi requisiti è in grado, in aziende artigiane che utilizzano impianti ad ultra-filtrazione con ricircolo dell’aria, come quelle monitorate in questo studio, di garantire il lavoro in condizioni di rischio analoghe a quelle realizzabili con impianti ad emissione esterna dell’aria. I campionamenti effettuati in due aziende con le caratteristiche descritte, hanno permesso di verificare che la media geometrica della concentrazione delle polveri nell’aria di ritorno dell’impianto di abbattimento è 0,05 mg/m3 ed è quindi inferiore, come dichiarato dal produttore, a 0,1 mg/m3, ed inferiore al limite di 0,2 mg/m3 indicato dalla norma UNI EN 12779 (punto 5.4.3.2.2). La media geometrica dei risultati ottenuti con i campionamenti nell’area di lavoro (0,13 mg/m3) evidenzia un valore di basso inquinamento ambientale. Analizzando i singoli valori, i dati mostrano che la situazione ambientale monitorata è accettabile in base ai criteri previsti nella UNI EN 689/97 (criterio formale); infatti tutte le misure sono 1/10 del valore limite occupazionale indicato per le polveri di legno nel D.Lgs. 81/2008. I campionamenti effettuati mostrano valori all’emissione dell’impianto inferiori a quelli misurati al centro stanza e ciò conferma che l’esposizione nelle falegnamerie è legata a problemi di dispersione di polveri non immediatamente captate in prossimità delle lavorazioni o risollevate da pavimenti ed altre superfici, nozione del resto richiamata anche nella norma UNI EN 12779: “…la causa primaria di contenuto di polveri nell’aria di lavoro è l’incapacità della cappa d’estrazione di catturare tutta la polvere generata ed il ritorno della polvere dalle superfici coperte di polvere (pavimento, prodotti, pulizia della macchina). Il contenuto di polveri residue nell’aria di ritorno (area filtrata reintrodotta nell’ambiente di lavoro) ha solo un’influenza limitata sulla concentrazione di polvere nell’area di lavoro”. In conclusione lo studio ritiene che l’impianto a riciclo con sistema di ultra-filtrazione costituisca una valida soluzione per attività artigianali, in assenza della possibilità di emettere all’esterno l’aria aspirata e che garantisca un miglioramento sicuro delle condizioni di lavoro nella maggior parte delle microimprese artigiane del legno che hanno volumi di lavoro relativamente contenuti. Tale impianto consente a queste attività di rimanere legate ai centri storici ed alle zone residenziali dove sono nate, che ne giustifica l’esistenza e ne permette la sopravvivenza.
IL CASO FOPPA PEDRETTI
Nel convegno “Polveri di legno: salute e sicurezza”, tenutosi nel 2008 sotto l’egida di Regione Lombardia, Clinica del Lavoro Luigi Devoto lano, Asl Como, Asl Vimerca Asl Provincia Milano, Università Insubria, fu presentata da E. Foppa Pedretti e A. Cazzago (Foppapedretti S.p.A./ Foppapedretti Tecnology S.r.l., Bergamo) la relazione “Compatibilità ambientale nella produzione di mobili in legno massello: esempio di applicazione pratica. Foppapedretti nacque nel 1 come azienda produttrice di giocattoli in legno, utilizzando anche materiale riciclato dagli scarti di altre falegnamerie; alla fine degli anni ‘50 le mutate esigenze del mercato resero necessaria la diversificazione dell’assortimento nella serie di articoli per la prima infanzia, trampolino di lancio dell’azienda e suo biglietto da visita per decenni; successivamente, negli anni ottanta, si aggiunse l’ideazione e la produzione di mobili per giardino e per terrazzo e di oggetti per la casa. Nel 2008 l’azienda occupava oltre duecento dipendenti, operanti in due unità produttive in provincia di Bergamo, che si estendevano per un totale di 152.000 metri quadrati, dove si svolgeva l’intero ciclo integrato di produzione, a partire dall’ideazione, proseguendo con la progettazione, fino a giungere alla lavorazione e trasformazione del legno massiccio in prodotti finiti, in larga parte oggetto di brevetto. L’identificazione di Foppapedretti con un’importante risorsa naturale come il legno, ha sempre orientato l’azienda verso la promozione ed il sostegno concreto di un nuovo modello di sviluppo, basato sulla compatibilità tra industria e salvaguardia ambientale. Esempi emblematici di questa filosofia sono l’appartenenza a Bioforest, un’associazione senza scopo di lucro, nata per volontà di un gruppo di industriali e piccoli imprenditori allo scopo di promuovere una cultura produttiva più sensibile, contribuendo concretamente al ripristino ed alla salvaguardia di risorse naturali in Italia e all’estero e l’ottenimento del marchio FSC (Forest Stewardess Council), che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Nella relazione si sottolineava il fatto che anche nel concepire il ciclo di lavorazione e nell’ideare i prodotti offerti ai consumatori la scelta di Foppapedretti è stata coerente coi principi sopra esposti: la scelta di utilizzare esclusivamente vernici a solvente acquoso, seppur onerosa dal punto di vista economico, ha portato alla drastica riduzione delle emissioni nocive nell’ambiente, con il recupero e reintegro dei residui di vernice, all’estrema sicurezza per gli operatori addetti ed alla garanzia di sicurezza per il consumatore, garantendo notevoli vantaggi per l’ambiente esterno e di lavoro. Del legno, per tradizione aziendale, non si butta via nulla: gli scarti di lavorazione vengono sfruttati in molteplici modi e, nell’ottica di un bilancio integrato di impatto ambientale, tutti residui di legno, trucioli e segagione vengono recuperati, frantumati e, mediante un processo molto elaborato, riuzati come combustibile per il scaldamento di tutti gli stabilimenti e degli uffici, senza l’utilizzo di alcun combustibile fossile. Sempre nella citata relazione si segnalava che “… nei mesi invernali, stante la maggior richiesta energetica, l’impatto carbonico nullo è reso possibile dall’utilizzo di n avanzatissimo impianto di irazione e parziale ricircolo: a all’interno degli stabilimenti viene continuamente aspirata, filtrata e parzialmente reimmessa nell’ambiente produttivo con il completo recupero delle polveri, il tutto nel completo rispetto dei più stringenti standard di igiene del lavoro e della norma europea EN 12779/2005 “Safety of woodworking machines – Chip and dust extraction systems with fixed insatallation – Safety related performances and safety requirements”, in particolare del punto 5.4.3.2.2 – “Residual dust in separator outlet/return air”. L’impianto, il primo del genere in Italia, è in regime di autorizzazione sperimentale da parte della Regione Lombardia, costantemente monitorato nel suo corretto funzionamento e con frequenti verifiche analitiche della concentrazione delle polveri di reimmissione e nell’ambiente di lavoro”. A conferma dell’efficacia del sistema, veniva riportato l’esito di un’indagine analitica sull’aria reimmessa, che dimostrava come il valore riscontrato (0.02 mg/ Nm3) fosse dieci volte inferiore ai limiti prescritti dalla Norma EN 12779 precedentemente citata (0.2 mg/Nm3) ed anche inferiore agli standard medi di polverosità dell’aria dell’ambiente esterno di molte zone della Provincia di Bergamo, come risultante da dati delle centraline ARPA. “…Di conseguenza – concludeva la relazione – estremamente confortanti sono anche i risultati relativi alle polveri nell’ambiente di lavoro, le cui concentrazioni medie risultano essere intorno a 0.4 mg/m3, con oscillazioni tra 0.22 e 0.69 mg/ m3, meno della metà del limite obiettivo regionale di 1 mg/m3…”, per cui “…la storia della nostra azienda dimostra come la meticolosa attenzione alla progettazione del prodotto e dei più minuti particolari del ciclo di lavorazione, unita ad un costante impegno di manutenzione e di monitoraggio, possa rendere decisamente limitato l’impatto ambientale globale della produzione di mobili in legno massello, con benefici effetti anche sulla tutela del lavoratore”. Nel 2014, i responsabili del PSAL di Bergamo (Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro) hanno confermato che l’azienda ha costantemente rispettato le prescrizioni autorizzative (emanate dalla Provincia, con parere positivo dello PSAL), che prevedevano controlli analitici trimestrali (autogestiti) nel primo anno di attività dell’impianto, semestrali dal secondo anno, con il costante controllo del medico competente. Da notare che la Provincia di Bergamo richiede sempre, su impianti nuovi, la canalizzazione delle emissione verso l’esterno, sia perchè lo impone la normativa, sia perchè è ritenuta economicamente più conveniente.
IL CASO DELLO STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE
Il Dipartimento Arpat di Pistoia ha attivato una sequenza di verifiche nell’ambito del settore stampaggio di materie plastiche. Si tratta di piccole e medie imprese che utilizzano le classiche presse ad asse orizzontale, nelle quali vengono prodotti articoli in polipropilene per processo di iniezione all’interno di stampi metallici. Secondo l’associazione di categoria che rappresenta queste aziende, le macchine installate in tutto il territorio nazionale non sono mai dotate (e nemmeno predisposte) di impianti di aspirazione, in quanto i dati di letteratura e varie campagne di campionamento non hanno mai evidenziato, date le modeste temperature di processo, presenza o concentrazioni di sostanze aereodisperse pericolose, derivante dal processo di decomposizione della materia prima, per la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Le presse sono sempre localizzate all’interno del luogo di lavoro, normalmente abbinate a piccoli impianti di triturazione degli scarti per il reimpiego nel ciclo di lavoro, quest’ultimi dotati di impianto di abbattimento delle polveri tramite piccoli cicloni e filtri a sacco di tessuto. Gli ispettori dell’Arpat hanno contestato la mancanza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, ma l’associazione di categoria segnala che l’art. 267 comma 1 ha precisato che il Titolo I della Parte V si applica agli impianti ed alle attività che producono “emissioni in atmosfera”, a differenza dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Dpr 203/88, che faceva riferimento a “tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell’atmosfera”. La Suprema Corte (sentenza della sez. III,15/12/2006 n. 40964) non ha mancato di sottolineare la differenza e ha affermato che “…l’esercizio di un impianto senza richiesta di autorizzazione configura un reato soltanto quando esista il presupposto previsto dalla legge, che si tratti cioè di un impianto capace di produrre emissioni in atmosfera. Mancando questo presupposto, la gestione dell’impianto non è soggetta alla richiesta di autorizzazione”. Queste considerazioni diventano ancor più cogenti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, poichè l’art. 267, comma 1, nel definire il campo di applicazione della nuova disciplina, precisa che essa si applica agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera, e con ciò si definisce in modo più rigoroso e restrittivo il presupposto del reato, che non è più la generica possibilità, ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell’impianto. Pertanto l’individuazione di una attività nell’elenco di cui alla Parte II dell’allegato IV degli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 non presuppone la diretta traslazione nell’obbligo di autorizzazione in quanto deve essere valutata la concreta attività di emissioni in atmosfera da parte dell’impianto. L’associazione di categoria ritiene quindi che in queste fattispecie gli esiti dei processi di Valutazione dei Rischi imposti dal d.lgs. 81/2008 non hanno mai ravvisato la necessità di installare un impianto di aspirazione con espulsione dei presunti inquinanti all’esterno dell’ambiente di lavoro e pertanto gli eventuali prodotti di decomposizione sono confinati all’interno del luogo di lavoro ed eventualmente raggiungono l’esterno solo attraverso i ricambi d’aria, quest’ultimi esclusi da obblighi autorizzativi. A mio avviso invece, proprio la citata sentenza della Suprema Corte specifica quali sono gli impianti capaci di produrre emissioni in atmosfera che richiedono un’autorizzazione (quelli elencati nel dlgs 152), per cui anche secondo vari Enti Pubblici competenti in materia, l’individuazione di un’attività nell’elenco di cui alla Parte II dell’allegato IV degli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 è più che sufficiente per essere considerata fonte di emissioni in atmosfera, indipendentemente dall’analisi di valutazione dei rischi.